La lavorazione degli oli
Questo Mulino diventa frantoio nel 1871 e da allora tratta semi oleosi
per la produzione di olio ad uso alimentare e industriale.
 Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino
che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da
Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo
la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e
raramente anche mandorle, arachidi e noci.
Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino
che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da
Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo
la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e
raramente anche mandorle, arachidi e noci.
I sacchi di juta contenenti i semi venivano scaricati a spalla e
portati nel magazzino del primo piano, cui si accedeva direttamente dalla via De Amicis
con la scala tuttora esistente nel locale del frantoio. Il primo piano era adibito a
magazzino per i vari tipi di semi, che venivano rovesciati direttamente in mucchi sul
pavimento di legno, perché i sacchi di juta facevano parte della dotazione del
trasportatore.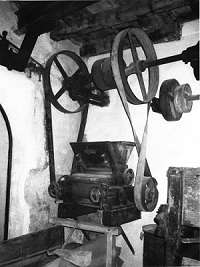
Con la pala i semi venivano posti su una cinghia di trasmissione a tasche
e portati nella tramoggia (a sinistra nella foto), ora sistemata al piano terra,
che con movimento orizzontale separava i semi dalle impurità per una prima pulizia. Le
impurità, dette anche "bruscaglie", venivano raccolte a parte; i semi invece
erano avviati in un cassone a forma di imbuto e da qui scendevano nel trituratore (nella
foto a destra) al piano terra.
Il trituratore a due cilindri era usato principalmente per il seme di
lino che, ridotto a farina, cadeva per terra; da lì veniva raccolto con la pala e portato
direttamente nel negozio o sistemato in sacchi. Se dalla farina di lino si voleva ricavare
l’olio, si portava il materiale nel forno per scaldarlo, e poi nella pressa.
La macina (nella foto a sinistra) ha una enorme ruota di
pietra di mt. 1,5 di diametro e cm. 40 di spessore detta "molazza" (che veniva
chiamata anche "rudun"), e porta incisa nella parete interna la data del 1871 in
caratteri alti cm. 20; essa ruotava con la forza dell’acqua perché collegata alla
ruota esterna che pescava nel Lambro.
 Questa
ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa
nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il
riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di
sostegno.
Questa
ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa
nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il
riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di
sostegno.
All’interno del Mulino è invece ben visibile lo spazio per una
grande ruota interna, sotto il livello del pavimento; il vano, ora coperto da un
cristallo, riguardava un’attività precedente legata alla follatura.
 Quando
la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito
con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno
(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname
recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,
per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.
Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli
attrezzi.
Quando
la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito
con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno
(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname
recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,
per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.
Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli
attrezzi.
 Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.
Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.
Il torchio (nella foto a destra) è una grossa macchina di
ghisa prodotta dalla ditta F.lli Pagnoni; ha nel centro un vano cilindrico dove viene
messo l’impasto a strati inframmezzato da dischi di ghisa e juta; dopo aver disposto
una decina di strati di semi, il torchio entra in funzione.
La pressione per far lavorare il torchio era fornita dalla pompa ad
acqua (a sinistra); essa sollevava dal basso l’acqua contenuta nel
basamento, ed esercitava nel torchio una pressione controllata da un manometro e
proporzionata al tipo di semi lavorati, schiacciando fortemente i vari strati di poltiglia
compresi fra i dischi di juta e di ghisa (conservati sino ad oggi come è possibile
vedere nella foto a destra). 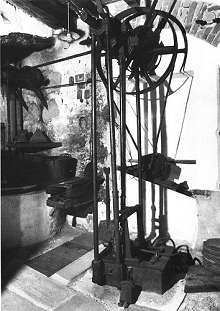 Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure
sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in
corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto
in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di
raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.
L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o
direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).
Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure
sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in
corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto
in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di
raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.
L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o
direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).
 A
questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno
pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto
ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.
A
questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno
pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto
ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.
Da un sacco di semi di lino di un quintale si ricavavano circa dieci
litri di olio. Da un sacco di germi di grano che pesava circa kg. 40 si ricavavano cinque
litri di olio; il germe di grano arrivava spesso dal Mulino della Cascinazza come
sottoprodotto della farina di granoturco.
I pannelli di scorie pressate, di forma rotonda come il diametro del
torchio, venivano venduti ai contadini che li adoperavano come mangime per gli animali;
essi avevano anche una funzione medicamentosa.

Il trasporto dell’olio veniva fatto con bidoni rinforzati da
grossi cerchi di ferro per sopportare il rotolamento quando si usavano i camion, mentre
per il trasporto leggero veniva usato il triciclo (visibile qui sopra) ancora
oggi esistente; il "veicolo" doveva essere fornito di regolare bollo annuale. I
bolli tuttora visibili sono quelli degli anni 1936, 1937 e 1938.
 Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino
che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da
Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo
la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e
raramente anche mandorle, arachidi e noci.
Il seme trattato prima della guerra 40-45 era principalmente quello di lino
che arrivava dalle colonie italiane in Etiopia, da Buenos Aires, dalla Turchia e da
Montevideo; durante la guerra si usava anche il ravizzone, il girasole e le mandorle. Dopo
la guerra e fino al 1969 il materiale principalmente usato è il germe di grano, e
raramente anche mandorle, arachidi e noci.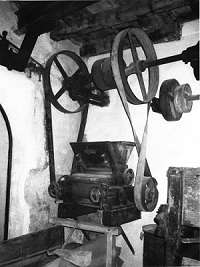

 Questa
ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa
nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il
riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di
sostegno.
Questa
ruota esterna non è più esistente, ma si vede, a livello del pavimento, la grossa
nicchia dove era innestato il perno, mentre all’esterno del Mulino è visibile il
riscontro del medesimo perno che si allungava sino ad appoggiare al muro centrale di
sostegno. Quando
la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito
con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno
(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname
recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,
per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.
Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli
attrezzi.
Quando
la schiacciatura con la macina era ultimata, l’impasto formatosi veniva trasferito
con una latta a due manici (esempio di recipienete nella foto a destra) nel forno
(visibile nella foto in basso a sinistra), alimentato da vinaccioli e legname
recuperato sulla chiusa della gora, asciugato e conservato nel sottoscala. L’impasto,
per non bruciare sul fondo, era mescolato in continuazione dalla pala a elica interna.
Sulla destra del forno è sistemato un piccolo tavolo di lavoro con il cassetto degli
attrezzi. Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.
Il materiale riscaldato era quindi pronto per essere pressato.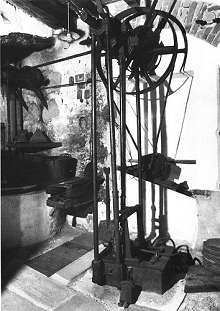 Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure
sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in
corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto
in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di
raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.
L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o
direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro).
Il risultato di questa pressione, e cioè l’olio, usciva dalle fessure
sul perimetro del cilindro centrale del torchio e si raccoglieva sul fondo, dove, in
corrispondenza di un ribasso del pavimento che si trova dietro al torchio, veniva raccolto
in una latta. L’olio così ottenuto veniva poi versato in un grosso bidone di
raccolta per la sedimentazione posto a destra della colonna di granito vicino alla scala.
L’olio veniva poi portato alla raffineria se doveva servire per uso alimentare, o
direttamente al cliente se veniva usato per l’industria (vernici, stucco, o altro). A
questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno
pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto
ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.
A
questa prima spremitura ne poteva seguire una seconda, con la quale si otteneva olio meno
pregiato, rompendo i pannelli di scorie usciti dal torchio, e rischiacciando il tutto
ancora con la molazza, e poi ripassando l’impasto al forno e al torchio.